La Resistenza nella Provincia di Forlì

Seconda parte
Leggi qui la prima parte
Di Davide Prati
Anche nei principali centri del Forlivese, l’8 Settembre dette l’avvio a spontanee manifestazioni popolari quali assalti a magazzini ed a caserme abbandonate del regio esercito. Molti giovani presero così “La Via dei Monti”, dando vita alle prime bande che caratterizzarono l’esperienza precoce della Resistenza nell’Appennino tosco- romagnolo. La situazione di sbando dovuta all’incapacità e, soprattutto, alla pavidità delle alte sfere (monarchia in primis) aveva lasciato l’Italia senza direttive ed alla completa mercé dei tedeschi invasori. Dalle ceneri della nazione, seppe però rialzarsi quella parte sana di italiani che non avevano mai chinato il capo dinnanzi al fascismo ed al suo fiume di violenze, un gruppo eterogeneo formato da antifascisti di vecchia data, ex garibaldini di Spagna, giovani decisi a voltare pagina, soldati del disciolto regio esercito ed altri ancora, ai quali si andarono presto affiancando combattenti stranieri (soprattutto slavi) catturati in precedenza durante l’invasione nazifascista dei loro stati ed imprigionati in Italia. Questi dettero vita alla Resistenza che nel forlivese fu molto consistente e particolarmente combattiva. Anche nel territorio dell’odierno Parco Nazionale, e nelle zone limitrofe ad esso, andarono costituendosi le prime “Bande”, o gruppi armati, che dettero presto inizio alla loro guerriglia. Tra le prime azioni ricordiamo l’uccisione, avvenuta a Santa Sofia il 23 Ottobre, del capitano tedesco a cui vennero trafugati i documenti riguardanti i piani inerenti alla neo costituenda Linea Gotica. Esemplari per quanto riguarda le azioni “spettacolari” furono i colpi della “Banda Corbari” che, in autonomia rispetto alle più grosse formazioni dell’Appennino (gli effettivi del gruppo rimasero sempre attorno alle 30-40 unità), operò tra l’Appennino forlivese e quello faentino. Silvio Corbari meriterebbe un approfondimento tutto suo che, per ovvi motivi di spazio e di tempo, non possiamo trattare nel presente lavoro; per ricordare alcune delle sue gesta più epiche ci limitiamo a citare “La Capanna del Partigiano” sul Monte Lavane, teatro di uno scontro tra La Banda Corbari e reparti tedeschi nel luglio del ’44 che costò a questi ultimi diverse perdite. Rammentiamo inoltre le occupazioni di Tredozio e di Modigliana (marzo e Maggio ’44) ed infine l’uccisione del comandante della guardia nazionale repubblichina Marabini a Predappio. Corbari fu tradito da una spiata mentre si trovava a Ca’ Cornio (sulle colline di Modigliana) assieme ad Iris Versari, Arturo Spazzoli e Adriano Casadei. Tristemente celebri sono le fotografie che li ritraggono impiccati nella piazza centrale di Forlì.
Il raggruppamento partigiano che in maniera più massiccia fu presente nel forlivese fu la Brigata Garibaldi Romagna, divenuta in seguito la celebre Ottava Brigata Garibaldi (come tutte le brigate Garibaldi, anche la nostra era di chiara ispirazione comunista). Uno dei primi nuclei della Resistenza del nostro appennino ebbe base a Pieve di Rivoschio già nelle prime settimane che seguirono l’armistizio. Al comando del suddetto gruppo troviamo un confinato siciliano: Salvatore Auria. La base venne attaccata dai tedeschi ai primi di novembre senza, fortunatamente, perdite da parte dei Partigiani che riuscirono a sottrarsi all’attacco. Le prime basi partigiane dell’appennino forlivese furono la Collinaccia, sopra Galeata, e la casa isolata di Val della Chiara, a monte di Corniolo, dove avvenne uno dei primi scontri a fuoco della nostra Resistenza (Ottobre 1943). Nel frattempo l’organizzazione militare si andò affinando ed organizzando, con la creazione del Comando dei Partigiani romagnoli affidato ad Antonio Carini (nome di battaglia Orsi), ex combattente di Spagna, coadiuvato da Ilario Tabarri (Pietro Mauri). Al comando della brigata, da dicembre, troviamo Riccardo Fedel (Libero) personaggio che la storiografia resistenziale avrebbe molto discusso negli anni del dopoguerra… Il suo progetto era quello di creare un grosso esercito partigiano, da costituirsi grazie ad un reclutamento simile a quello che veniva fatto negli eserciti regolari. Tuttavia, più che i bandi partigiani, ad infoltire le schiere della brigata, ci “pensarono” i bandi d’arruolamento emanati dalla neocostituita Repubblica Sociale Italiana (RSI), ovvero il governo fantoccio presieduto da Mussolini nei territori del centro e del nord Italia non ancora raggiunti dall’avanzata alleata. I Partigiani erano stanziati a Corniolo dove, grazie all’isolamento della zona dovuto alle forti nevicate, avevano dato il via ad una sorta di “Repubblica Partigiana” (e qui vien facile il rimando ideale a Fenoglio con la città piemontese di Alba) definita “Dipartimento del Corniolo”. L’ aumentato numero dei Partigiani (parliamo di oltre novecento uomini, buona parte dei quali non aveva né armi né, e questa sarebbe stata una delle principali critiche mosse in seguito da Tabarri a Libero, preparazione o consapevolezza “politica”) e il miglioramento meteorologico marzolino costrinsero la brigata a lasciare il Corniolo per Strabatenza (parrocchia oggi semi fantasma, sita nell’alto ramo dell’omonimo fiume Bidente, nel Comune di Bagno di Romagna). Tabarri, che in quei giorni aveva sostituito Libero, decise di dividere la brigata in 3 gruppi per meglio muoversi (ricordiamo che al vertice di ogni brigata era prevista la doppia figura del Comandante Militare e del Commissario Politico). I primi due gruppi si mossero così in direzione delle Marche, passando dal Monte Fumaiolo e Sant’Agata Feltria, mentre il terzo gruppo sarebbe rimasto a vigilare sull’altipiano di San Paolo in Alpe dove si attendeva un lancio di materiali ed armi da parte di aerei alleati. I piani di Tabarri non poterono essere attuati a causa del “grande rastrellamento d’Aprile” che tedeschi e fascisti avevano iniziato in quei medesimi giorni, tra Marche, Romagna e Toscana, con l’obiettivo di liberarsi definitivamente della presenza partigiana nelle proprie retrovie. Il nostro Appennino sarebbe diventato nei mesi successivi campo di battaglia non solo per la guerriglia partigiana e polizia fascista, bensì per gli eserciti tedesco ed alleato. Sfruttando la conformazione delle montagne, perfetta per la guerra difensiva che il Terzo Reich stava combattendo in Italia e che permetteva ai tedeschi di sopperire alla netta inferiorità in uomini ed armamenti rispetto alle armate angloamericane, i vertici militari e politici nazisti avevano deciso la costruzione, passante anche per l’Appennino forlivese, della celebre Linea Gotica (ovvero un insieme di difese in profondità che tagliava l’Italia in due: da Massa Carrara a Pesaro). Per l’esercito tedesco era di fondamentale importanza la percorrenza dei passi dell’Appennino per rifornire le truppe che combattevano a sud sulla Linea Gustav. Ancora oggi, ad un escursionista attento che si trovi a percorrere i sentieri della Campigna, potrà capitare di imbattersi nei resti delle fortificazioni o dei camminamenti approntati dai tedeschi (o meglio dai lavoratori coatti italiani arruolati nell’Organizzazione Todt).
Il rastrellamento fu particolarmente pesante in termine di perdite per i Partigiani che ne uscirono con le ossa rotte. Le file della brigata furono completamente scompaginate e tutto il materiale, faticosamente messo assieme nei mesi precedenti, andò perso. La ferocia nazifascista non si limitò ai soli combattenti partigiani ma si rivolse anche (e spesso in maniera ancora più feroce) contro la popolazione civile. Stiamo parlando della triste strategia teutonica della Guerra ai Civili che inflisse una lunga fila di lutti alle nostre popolazioni (per rimanere alla nostra provincia ricordiamo qui le stragi di Tavolicci, comune di Verghereto, Sodelle, comune di Santa Sofia, e Colle del Carnaio, comune di Bagno di Romagna: tre esempi che purtroppo ben si inseriscono in questa sporca guerra agli inermi).
La più celebre battaglia sostenuta dai Partigiani durante il rastrellamento d’Aprile ebbe luogo a Biserno (Santa Sofia) dove i Partigiani, schierati sul crinale, riuscirono per diverso tempo a respingere gli assalitori. Il tradimento di un abitante del posto (Berleta), che indicò ai nazifascisti un percorso nascosto capace di portarli alle spalle delle difese partigiane, decretò la rottura delle linee difensive dei patrioti ed il completo annientamento del gruppo partigiano (in totale caddero sul campo 11 giovani combattenti della Libertà). Per rimanere alla triste trattazione dei Partigiani caduti, faccio qui un salto indietro rispetto alla narrazione cronologica di un paio di mesi, tornando al Febbraio del ’44, mese al quale risale il primo morto tra le file dei nostri Partigiani, ovvero il giovane santasofiese Guido Buscherini (nome di battaglia Stoppa) caduto nei pressi del Monte Tiravento dopo lo sfortunato (ed improvvisato) attacco partigiano alla caserma di Premilcuore.
Il rastrellamento, per quanto duro e ben organizzato, non riuscì tuttavia ad eradicare la presenza partigiana dall’Appennino. Nei mesi successivi i Partigiani seppero riorganizzarsi e riprendere l’offensiva in vista di un ormai prossimo avvicinarsi del fronte (parimenti ripresero anche i tentativi di repressione e le violenze nazifasciste).
All’inizio dell’estate l’Ottava Brigata Garibaldi aveva raggiunto i 500 effettivi e si apprestava ad appoggiare gli Alleati ormai prossimi. I rapporti con questi non furono facili data la pregiudiziale anticomunista che li animava (particolarmente difficili furono quelli con il corpo polacco apertamente anticomunista!). Questa ed altre motivazioni, fecero si che l’Ottava Brigata Garibaldi venisse disarmata il prima possibile, impedendole di raggiungere Forlì e di prendere parte alla sua Liberazione.


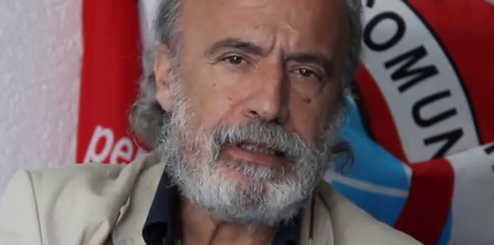



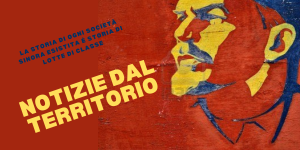








Che bell’articolo! Chiaro e dettagliato
Narrazione credibile,manca però la spiegazione del fatto che chi disarmò la ottava utilizzò la ventottesima ugualmente comunista fino alla fine. John combe probabilmente fu decisivo nelle decisioni prese